L’accordo raggiunto al Consiglio Europeo del 18 e 19 febbraio per persuadere il primo ministro britannico a non sostenere l’uscita del Regno Unito dalla UE ha a quanto pare suscitato reazioni contrastanti tra gli europeisti. Un comunicato del Movimento Federalista Europeo rileva che viene fatta finalmente chiarezza sul rapporto tra Londra e il resto della UE, e che ora gli altri paesi possono proseguire nell’unificazione politica dell’Europa senza più alibi.
È una posizione condivisa tra gli altri dall’europarlamentare Roberto Gualtieri in un’intervista al quotidiano La Repubblica e dall’ex candidato ALDE alla presidenza della Commissione Europea Guy Verhofstadt. Altri per converso sottolineano le implicazioni di questo accordo, con cui vengono sacrificati il principio di non discriminazione tra cittadini UE, il principio dell’uguaglianza tra i paesi UE (remember Greece?), la democrazia e la trasparenza stessa sul piano europeo, se è vero che viene alterato l’assetto fondamentale UE senza dibattito e senza coinvolgimento né dei parlamenti nazionali né del Parlamento Europeo.
Così si sono espressi ad esempio la co-presidente del Partito Verde Europeo Monica Frassoni, l’eurodeputata ALDE Sylvie Goulard, il verde franco-tedesco Daniel Cohn-Bendit, e l’autore dell’articolo che vi proponiamo sotto. Può benissimo darsi che tale differenza di vedute sia solo attribuibile a una visione soggettiva della situazione, un po’ come chi guarda lo stesso bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Può però anche darsi che essa rimandi a una diversa visione delle priorità in materia di Europa sociale e democrazia europea. È bene quindi discuterne anche tra noi europeisti e federalisti. Prima che sia troppo tardi.
- Ue e Regno Unito: la vittoria dei liberisti di Marco Bascetta (Il Manifesto, 21 febbraio)
Referendum Brexit il 23 marzo. Quella a cui abbiamo assistito è l’ennesima vittoria delle élites finanziarie nel loro complesso su tutti i cittadini del Vecchio continente. O, per dirla in termini ormai messi al bando, dell’accumulazione di capitale sulla libertà della forza lavoro. Non si è trattato, insomma, di un poker diplomatico, o di una pura e semplice esibizione a beneficio delle opinioni pubbliche nazionali, ma di un esempio da manuale della lotta di classe. Quella condotta dall’alto, naturalmente
Nella classica ottica nazionale, che sempre meno spiega e sempre più mistifica, si potrebbe sostenere che il Regno unito l’ha spuntata sull’Europa continentale, almeno su quella sua parte che ancora sventola, ormai più a parole che a fatti, la bandiera dell’integrazione. Non è così.
Quella a cui abbiamo assistito è l’ennesima vittoria delle élites finanziarie nel loro complesso su tutti i cittadini del Vecchio continente. O, per dirla in termini ormai messi al bando, dell’accumulazione di capitale sulla libertà della forza lavoro. Non si è trattato, insomma, di un poker diplomatico, o di una pura e semplice esibizione a beneficio delle opinioni pubbliche nazionali, ma di un esempio da manuale della lotta di classe. Quella condotta dall’alto, naturalmente. Ma procediamo con ordine.
Già da diverso tempo è stata coniata, e circola con sempre maggiore insistenza, l’orribile espressione di «turisti del welfare». Si intende con questa insolente definizione il nomadismo dei lavoratori precari attraverso i paesi dell’Unione alla ricerca di contesti, occasioni, diritti e livelli di vita più soddisfacenti. L’intermittenza e il nomadismo sono, a ben vedere, le caratteristiche più peculiari di una parte crescente della forza lavoro contemporanea che nessuna pianificazione nazionale potrà mai riassorbire. Sono l’espressione di modelli produttivi ormai affermati.
La mobilità è infatti un requisito professionale e, al tempo stesso, una delle risorse principali attraverso le quali, in assenza di diritti comunitari omogenei, i singoli possono tentare di costruirsi un habitat, sia pure provvisorio, che corrisponda in qualche modo alle loro aspettative. La pretesa britannica di negare o ridurre le prestazioni sociali per 13 anni (ne hanno ottenuti poi «solo» 7) ai lavoratori in provenienza da altri paesi dell’Unione è un attacco diretto alle condizioni di vita di questo precariato in movimento e un deciso passo avanti nell’organizzazione gerarchica della vita sociale.
Vi sono pochi dubbi che questa voce di «risparmio» possa far gola ad altri paesi con welfare molto sviluppato e forse non solo a quelli. Anzi, è quasi inevitabile che la discriminazione diventi una regola. Si assisterebbe così a una nobile gara a rendersi il più inappetibili possibile per il «turista del welfare», il parassita intracomunitario per antonomasia. Sull’esempio di analoghe politiche di deterrenza, teorizzate e praticate da paesi come la Danimarca e la Svezia nei confronti dei richiedenti asilo, ai quali si prospettano e poi si impongono condizioni di accesso sempre più proibitive e vessatorie. Il rapporto con i migranti, è bene tenerlo a mente, ci riguarda tutti molto da vicino. Il risvolto politico è immediato. La non discriminazione, quanto a diritti e garanzie, dei cittadini europei che risiedono e lavorano in un paese diverso da quello di origine era forse l’unico ambito in cui la cittadinanza europea risultasse davvero effettiva.
Tanto che paradossalmente solo spostandosi si poteva avere la percezione di goderne i vantaggi. La limitazione imposta da Londra (con il solito pretesto di una inesistente emergenza a cui metter freno) e le emulazioni che certamente ne seguiranno, assestano così, assieme al continuo ripristino dei controlli di frontiera, un colpo mortale alla già fragile cittadinanza europea. C’è poco da stupirsene visto che il Regno unito vede da sempre l’Europa politica come il fumo negli occhi. Ma anche da altri paesi del continente si levano voci di ringraziamento a David Cameron per aver contribuito ad allontanare l’incubo di una maggiore integrazione politica in Europa.
A tutti è chiaro, anche se nessuno vuole ammetterlo esplicitamente, che lo statuto particolare concesso al Regno Unito comporta riflessi assai rilevanti per tutta l’Unione, ben oltre i contenuti effettivi del “compromesso” raggiunto a Bruxelles. Tutti si sentiranno meno vincolati, tutti autorizzati a issare la bandiera della «priorità nazionale». Ma, soprattutto, la permanenza della Gran Bretagna nell’Unione, paese ritenuto il più squisitamente liberista e devoto al libero mercato, viene apprezzata come un antidoto a qualsiasi rischio di «deriva» sociale o solidaristica dell’assetto comunitario.
C’è infatti un «turismo» che, a differenza di quello del welfare, è decisamente più gradito. È il turismo delle condizioni fiscali migliori, della deregulation più permissiva, del costo del lavoro più basso e dei lavoratori più indifesi. Il turismo del capitale non prevede né visti né dilazioni e pretende sempre accoglienza trionfale. La City non intende affatto «armonizzarsi» con le regole bancarie dell’eurozona, ma non rinuncia a operare in piena libertà e senza impedimenti di sorta nello spazio del mercato comune. Il protezionismo applicato alla circolazione delle persone non si applica a quella dei capitali.
Certo, non sono mancate preoccupazioni e proteste per la concorrenza che istituti finanziari senza vincoli possono esercitare nei confronti di istituti sottoposti a regole, né riguardo a quanta voce in capitolo, senza alcuna contropartita in termini di obblighi, avrà effettivamente Londra sulle decisioni e gli orientamenti dell’Unione europea. Ma il sistema della competitività e la fede nel mercato sembrano avere prevalso su questo ordine di preoccupazioni. Alla spregiudicata compagnia della City non si vuole comunque rinunciare. Se qualcuno immaginava uno scontro aspro tra l’ordoliberalismo tedesco e il liberalismo anglosassone sarà rimasto deluso.
Inoltre, tutta questa faticosa messa in scena potrebbe non servire a nulla. Il 23 giugno i britannici voteranno sulla permanenza del loro paese nell’Unione e, tra nostalgici dell’impero, filoatlantici e nazionalisti xenofobi, il bottino di Cameron rischia fortemente di non bastare a evitare il Brexit. Del resto possiamo essere certi che il referendum in Gran Bretagna non farà la fine di quello di Atene. Ma, visto il ruolo che vi svolge e che le élites finanziarie le assegnano, dovremmo davvero disperarci per il commiato della Gran Bretagna dall’Unione? Dalla quale, per quel che ci preme, si può dire che sia già fuori.








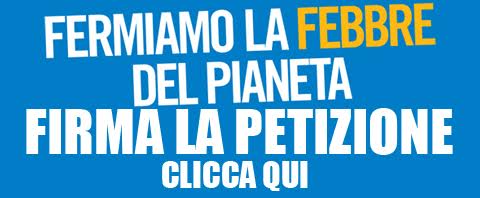





 Europa in Movimento | Developed by
Europa in Movimento | Developed by