Articolo 11 della Costituzione italiana: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Caratterizzano questo principio fondante della nostra Repubblica due concetti di democrazia: da una parte la pace come rifiuto della guerra, come strumento offensivo (ma non come strumento difensivo) e dall’altra la “limitazione” della sovranità nazionale in favore di ordinamenti sovraordinati e la promozione di entità supernazionali, che garantiscano la realizzazione della pace.
Era intenzione dei Padri costituenti riferirsi all'Organizzazione delle Nazioni Unite, alla cui adesione la “pace”, inserita come obiettivo nell’ordinamento costituzionale, fungeva da chiave di accesso.
L’articolo 11 è stata ritenuto il fondamento anche dell'adesione italiana alla CECA, alla CEE e poi all'Unione Europea (secondo una lettura avallata dalla stessa Corte Costituzionale, 18 dicembre 1973, n. 183, 5 giugno 1984, n. 170, 19 aprile 1985, n. 113).
Questo riconoscimento di principio si è concretizzato con la preminenza del diritto comunitario su quello nazionale, immediatamente applicabile. La Corte Costituzionale, nel corso del tempo, ha formulato la c.d. teoria dei “controlimiti”, in base alla quale la prevalenza deve comunque “garantire il rispetto dei diritti della persona e dei principi fondamentali dell'ordinamento” (Corte Costituzionale, 18 dicembre 1973, n. 183). Il principio di primazia del diritto comunitario ha trovato esplicita affermazione nell'articolo 117 della Costituzione. In quest’ultimo articolo si rinviene il cardine delle competenze in tema di potestà legislativa; questo non può essere svincolato dall’articolo il 118 della Costituzione che mette i princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza al centro dell’azione degli enti “concentrici”, cioè Comuni, Province e Città metropolitane, che insieme allo Stato e alle Regioni devono favorire – afferma l’articolo 118 – “l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
E’ questo – a mio avviso – il fondamento della solidarietà istituzionale.
Il principio di sussidiarietà – insieme a quello di differenziazione e di adeguatezza - è relativamente recente nell’ordinamento costituzionale italiano: l’articolo 118 è stato introdotto con la legge costituzionale n. 3/2001; prima di questo il nostro ordinamento si differenziava nettamente da altri impianti costituzionali influenzati dal federalismo, come gli Stati Uniti e la Germania ma anche dall’ordinamento dell’Unione Europea.
L’Unione Europea, il suo sviluppo istituzionale, è un modello che deve trovare forza nell’azione anche delle Comunità locali.
E’ nel suo seno che si è insediato il principio di sussidiarietà, ben prima che nel nostro ordinamento e di questo dobbiamo esserne consapevoli.
E’ stato sotto l'impulso di Altiero Spinelli che il Parlamento europeo approvò il 14 febbraio 1984 un progetto di Trattato come avvio del processo di costituzionalizzazione dell'Unione europea, che ha condotto alla revisione dei Trattati istitutivi delle Comunità europee (Atto unico, Trattato di Maastricht e quelli di Amsterdam, di Nizza e di Lisbona passando per il tentativo, fallito, di Trattato costituzionale del 29 ottobre 2004).
Altiero Spinelli pensò di condurre il Parlamento europeo, unico organo europeo eletto a suffragio universale e diretto, fuori dal suo semplice ruolo “consultivo” e diventare il perno della democrazia europea, avviando il processo costituente.
Nel Progetto Spinelli si trovava l'articolo 12 che introduce il concetto che, “nel campo delle competenze concorrenti, l'azione dell'Unione è necessaria laddove essa si riveli più efficace rispetto all'azione degli Stati membri, in particolare quando le dimensioni dell'azione dell'Unione o i suoi effetti vanno al di là delle frontiere nazionali” (Paolo Ponzano).
Si tratta della prima chiara definizione del principio di sussidiarietà.
A seguito della riforma dei Trattati comunitari operata nel 2007 dal Trattato di Lisbona, il principio di sussidiarietà, che nel 1992 era stato inserito nel Trattato sulla Comunità Europea (articolo 5), è ora contenuto nell’articolo 5 del Trattato sull’Unione Europea.
Concludo ricordando la Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione, Meuccio Ruini, che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (1947); in commento all’articolo 11 si legge: “Rinnegando recisamente la sciagurata parentesi fascista l'Italia rinuncia alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libertà degli altri popoli (…) si dichiara pronta, in condizioni di reciprocità e di eguaglianza, a quelle necessarie (limitazioni alla sua sovranità) per organizzare la solidarietà e la giusta pace fra i popoli. Contro ogni minaccia di rinascente nazionalismo, la nostra costituzione si riallaccia a ciò che rappresenta non soltanto le più pure tradizioni ma anche lo storico e concreto interesse dell'Italia: il rispetto dei valori internazionali”. A questi valori le Comunità locali hanno il dovere, anche morale, di conformarsi.








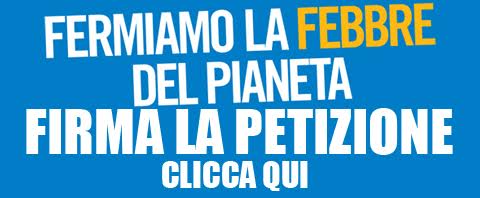





 Europa in Movimento | Developed by
Europa in Movimento | Developed by